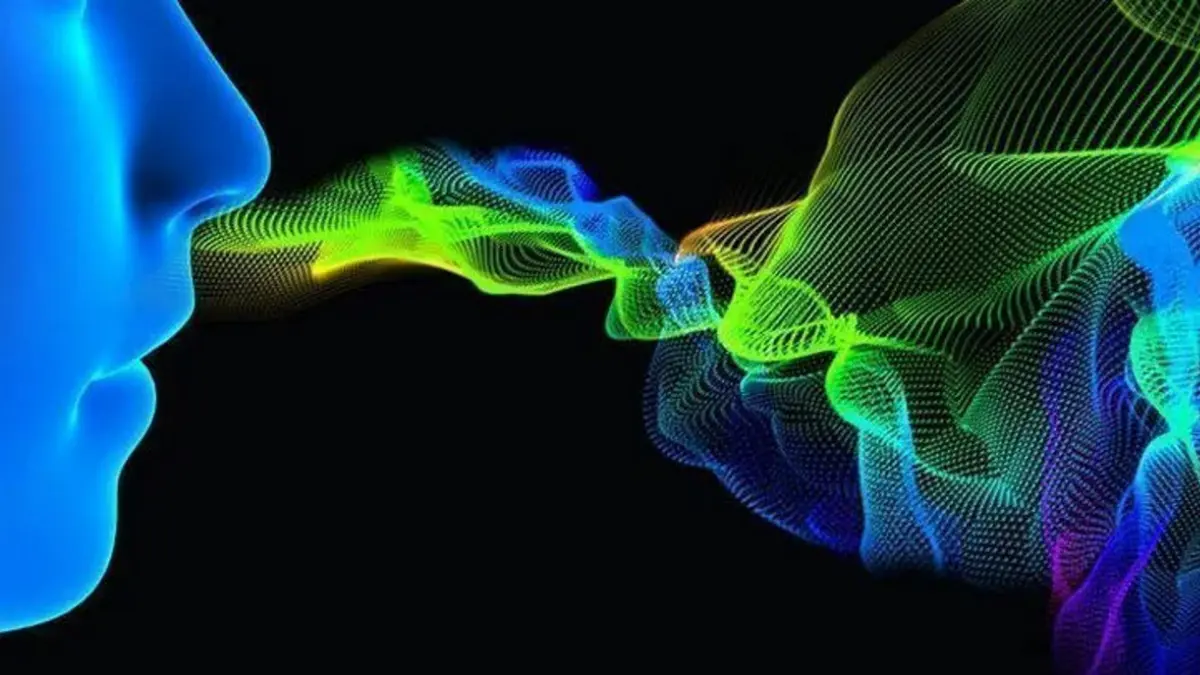La perdita o l’alterazione dell’olfatto è un disturbo più comune di quanto si pensi, ma ancora oggi troppo spesso trascurato, sia dal paziente che dal medico. Eppure, il senso dell’olfatto gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana, ben oltre la semplice percezione degli odori: influenza il gusto, condiziona le abitudini alimentari, partecipa alla memoria e alle emozioni, contribuisce alla sicurezza personale (ad esempio, nell’identificare gas, fumo, cibi avariati).
Un deficit olfattivo può avere un impatto rilevante sulla qualità di vita. La difficoltà nel percepire gli odori può portare a un calo dell’appetito, a un minore piacere nel mangiare e, nei casi più severi, a malnutrizione o perdita di peso. Alcuni individui tendono a compensare aumentando il consumo di sale o zucchero, comportamento rischioso in presenza di condizioni come ipertensione o diabete.
Un problema sottostimato e difficile da descrivere
Molte persone non sono pienamente consapevoli della propria perdita olfattiva, oppure faticano a descriverla in modo preciso. Spesso si riferisce una “perdita del gusto”, quando in realtà il gusto vero e proprio (cioè la percezione di dolce, salato, acido e amaro) è conservato: ciò che viene a mancare è la componente aromatica degli alimenti, che dipende principalmente dall’olfatto retronasale. Questo rende la diagnosi più complessa e contribuisce alla sottovalutazione del disturbo.
Le principali forme di disfunzione olfattiva
Le alterazioni dell’olfatto si classificano in diverse categorie, a seconda della natura del disturbo:
- Anosmia e Iposomia: perdita completa della capacità di percepire gli odori. Indicano la mancanza o la carenza dell’olfatto, che può essere dovuta a malattie (polipi nasali, naso chiuso da infezione virale, malattie neurovegetative), condizioni temporanee come il trattamento con farmaci (alcuni antibiotici o antistaminici), o una radioterapia, fattori come fumo, problemi dentali o l’esposizione a sostanze chimiche come insetticidi o solventi; l’anosmia può essere provocata anche da traumi cranici.
- Parosmia (o disosmia) e Fantosmia: percezione distorta di un odore reale, spesso sgradevole e percezione di odori inesistenti, in assenza di stimoli odorosi reali.La prima descrive un cambiamento nella percezione degli odori: un aroma familiare risulta distorto o diverso, oppure qualcosa che di norma ha un buon profumo viene considerato disgustoso (in questo caso si definisce anche disosmia); la fantosmia è invece la percezione di odori che non esistono nella realtà.
- Iperosmia: E’ l’ipersensibilità agli odori, molto meno comune della perdita dell’olfatto: in queste persone la soglia di percezione degli odori è molto bassa, perciò se da un lato possono riconoscerne di minimi e impercettibili, dall’altro possono essere infastidite da quelli di intensità normale.
Queste condizioni possono manifestarsi in modo transitorio o permanente, e avere cause molto diverse tra loro.
Come funziona l’olfatto
Il senso dell’olfatto dipende dal buon funzionamento del nervo olfattivo (I nervo cranico), che trasmette la percezione qualitativa degli odori, e dal nervo trigemino (V nervo cranico), coinvolto nella percezione somatosensoriale degli odori, come il bruciore, il fresco o la sensazione irritativa.
I recettori olfattivi sono localizzati in una piccola area dell’epitelio olfattivo, situata in alto nella cavità nasale, vicino alla lamina cribrosa dell’etmoide. Un danno in quest’area – dovuto a infiammazione, infezione o trauma – può compromettere significativamente la funzione olfattiva.
Diagnosi e inquadramento clinico
L’approccio diagnostico parte da una anamnesi dettagliata, che esplori l’insorgenza, la durata, l’associazione ad altri sintomi e l’eventuale assunzione di farmaci. L’esame obiettivo del naso, eventualmente completato con endoscopia nasale, è essenziale per identificare eventuali ostruzioni o infiammazioni.
In presenza di segni neurologici o quando si sospettano cause centrali, si può ricorrere a indagini di imaging come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica cerebrale. Esistono inoltre test olfattivi standardizzati, utili per quantificare il deficit e monitorarne l’evoluzione.
Quando intervenire
In molti casi, la causa del disturbo è trattabile. Ad esempio:
- polipi nasali o masse ostruttive possono essere rimossi chirurgicamente;
- le riniti e le sinusiti croniche possono rispondere bene a trattamenti farmacologici (come corticosteroidi locali o sistemici);
- la sospensione o la sostituzione di farmaci può risolvere il problema.
Nei casi in cui la disfunzione sia persistente, inspiegabile o associata a un marcato peggioramento della qualità di vita, è indicato l’invio a uno specialista, in genere un otorinolaringoiatra, per approfondimenti.
L’alterazione dell’olfatto è un segnale che non va sottovalutato. Può rappresentare il sintomo iniziale di patologie locali o sistemiche, e incidere in modo significativo sul benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. Un corretto inquadramento clinico consente nella maggior parte dei casi di identificare la causa e, quando possibile, di intervenire in modo mirato.