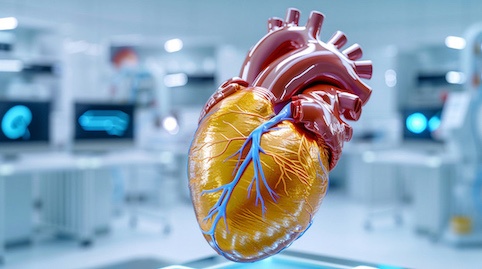E’ noto che il cuore, dopo aver subito danni, non possa essere del tutto riparato. Fino ad oggi la scienza non è riuscita ad offrire una soluzione al problema, ma sembra che una ricerca pubblicata su “Call Reports” e condotta da un team internazionale coordinato dall’Università di Bologna e Irccs – Policlinico di Sant’Orsola, dia una speranza al cuore di tantissime persone.
Il gruppo di ricerca ha indicato un percorso da seguire nel tentativo di riparare il muscolo cardiaco dopo aver subito danni dovuti ad infarti, terapie e infezioni di vario tipo. La letteratura medico – scientifica spiega che generalmente, ad esempio in seguito ad un infarto, il flusso sanguigno verso una parte del cuore risulta ostruito, le cellule muscolari cardiache (cardiomiciti) non ricevono abbastanza ossigeno e muoiono, cellule che tra l’altro non vengono sostituite da nuove cellule funzionali. In più, il processo di riparazione che si attiva forma una cicatrice di tessuto fibrotico caratterizzato da rigidità e scarsa elasticità, il che compromette, non di poco, la capaicità del cuore di pompare sangue in maniera efficiente.
La base di partenza del lavoro degli scienziati, coaudiuvato dal prof. Gabriele D’Uva dell’Università di Bologna, è stata la scoperta, fatta circa 10 anni fa, che i mammiferi (forse anche l’uomo), possiedono una buona capacità di rigenerare il cuore fino alla nascita, ma la perdono subito dopo, e oltretutto in maniera rapida. La ridotta capacità rigenerativa sarebbe quindi legata alla diminuizione dei fattori di crescita, ovvero proteine che il nostro organismo genera per stimolare la divisione cellulare.
“Il primo passo – spiega il prof. D’Uva – è stato individuare i fattori di crescita che dopo la nascita si riducono in maniera significativa all’interno del muscolo cardiaco. Li abbiamo testati per accertare la loro capacità di stimolare la proliferazione delle cellule del cuore, e così abbiamo individuato BMP7 uno specifico fattore di crescita, e lo abbiamo identificato come un elemento chiave”.
La conseguenza è stata l’ipotesi concreta di poter migliorare significativamente la funzione cardiaca. La ricerca è andata avanti cercando conferme nei modelli animali, ma non nella sperimentazione clinica destinata alle persone. “Reputiamo promettente il nostro lavoro, ma noi non conduciamo direttamente ricerca clinica – conclude D’Uva. Per questo, ci auguriamo che, in futuro, altri gruppi d ricerca scientifica possano esplorare l’applicazione della strategia che prevede l’utilizzo di BMP7 in pazienti con danni cardiaci, per verificare che gli effetti positivi osservati possono essere confermati”:
Il lavoro si trova quindi ad una fase preclinica, ma la strada è tracciata e il lavoro eccellente dell’equipe sta già pianificando ulteriori studi che si basano si soluzioni combinate.
Elena Grasso