Il limoncello è conosciuto per l’arte delle nonne che lo hanno preparato. Ma la sua bontà dipende particolarmente dalla freschezza e dalla coltivazione del limone, antico dono della terra arrivato da lontano.
“Tutto in questi alberi incanta gli occhi, soddisfa l’odorato, eccita il gusto e nutre il lusso e le arti”. Scriveva così in Pomona italiana alla fine del 1700 il conte Giorgio Gallesio, naturalista entusiasta, politico e diplomatico, dirigente pubblico e botanico italiano, sepolto tra gli uomini illustri nel chiostro della Basilica di Santa Croce in Firenze, introducendo la dimensione scientifica nella trattazione dell’albero del limone.
E J. W. Goethe fa dire a Mignon, personaggio femminile del suo romanzo: “Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?
Brillano tra le foglie cupe le arance d’oro……
Laggiù! Laggiù!
O amato mio, con te vorrei andare!
Siamo nel 1795 e Goethe si riferisce in particolare alla Sicilia che ha visitato e di cui si è innamorato.
Quella del limone è una storia lunga più di 4000 anni. Cresceva spontaneamente in Persia, Palestina, Cina, Malesia, Giappone, India, nei contrafforti dell’Himalaya, tanto che il suo nome deriverebbe da idiomi linguistici orientali, dal persiano limun e dall’arabo laimun.
Nelle valli dell’Indo gli scavi archeologici ne hanno scoperto tracce risalenti al 2500 a.C. e negli scavi di Mohenjo Daro in Pakistan è stato trovato uno splendido orecchino a forma di limone.
Sono stati trovati limoni disegnati, insieme a datteri e fichi, sulle pareti delle tombe nella Valle dei Re nell’antico Egitto dove venivano usati anche come sostanza per imbalsamare le mummie.
In Grecia li portò Alessandro il Grande, re di Macedonia, dopo le campagne vittoriose contro i Persiani. Li chiamarono “mele persiane” ed anche “pomo della Media”, come fece ilbotanico Teofrasto di Iresia nel IV-III secolo a.C.
Non a caso uno dei primi nomi botanici del limone è Citrus medica cioè proveniente dalla Media, la terra degli antichi persiani.
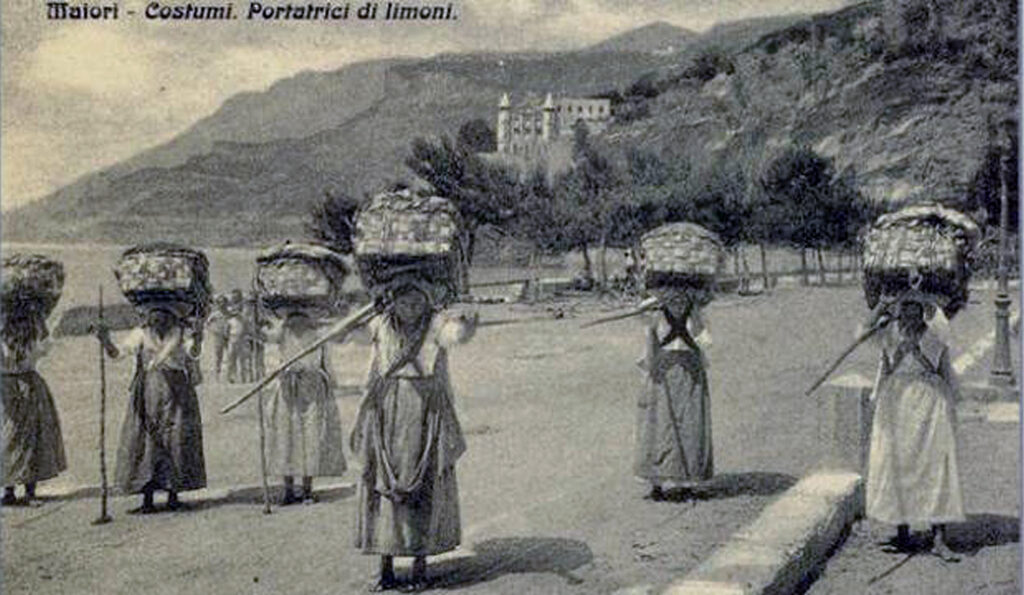

In Grecia il limone dorato incrociò la fantasia mitologica: Gea, la Dea della Terra, aveva donato alla dea Giunone, in occasione del suo matrimonio con Giove, un bellissimo giardino dove fiorivano le piante per gli dei. Le Esperidi, Aegle per il cedro, Aretusa per il limone, Hesperetusa per l’arancio, avevano avuto l’incarico di custodirlo ed avevano messo a guardia del giardino un drago.
Ma Ercole, in una delle sue 12 fatiche, riuscì a sconfiggere il mostro e a portare i frutti agli uomini.
La mitologia affascina ma ancora una volta ne riscontriamo un riferimento perché il limone viene chiamato anche esperidio in botanica.
Il limoncello è il liquore prodotto dalla macerazione in alcol etilico delle scorze di limone ricche di oli essenziali. L’infuso, filtrato dopo 48/72 ore, viene imbottigliato per maturarvi per un mese.
Il primo limoncello sembra sia stato preparato in Campania ma anche in Sicilia dove i Greci, che aggiungevano anche il succo dei limoni maturi per disinfettare e purificare l’acqua, probabilmente trasferirono tale uso nelle loro colonie.
Anche i Romani, quando conquistarono l’Oriente, vennero attratti dalle tante proprietà del frutto che Virgilio nelle “Georgiche” chiama “mela dei Medi” e dagli schiavi persiani impararono a preparare cibi e bevande rinfrescanti con i limoni. Il master chef Apicio consiglia l’uso della polpa bianca nella preparazione del maiale per diminuirne il gusto selvatico e il personaggio Trimalcione nelle sue cene si fa un vanto del potere offrire ai suoi ospiti i preziosi frutti esotici.
I romani li utilizzarono nella cucina da campo durante le campagne di conquista portandoli in Spagna, Francia, Italia del nord e in Nord Africa.
E qui ci vengono in soccorso i ritrovamenti archeologici: sembra che il più antico limone del Mediterraneo risalga al 14 d. C., trovato nel Carcer Tullianum del Foro romano di Roma, utilizzato forse per riti votivi, e testimonianze pittoriche dei limoni sono in Sicilia, nei mosaici della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, e in Campania a Pompei nella Casa del Frutteto. Qui lo studioso Casella riconosce il Femminello ovale comune, il Femminello sfusato, il Lunario o Palermitano, l’Arancino.
Se il limoncello è legato alla territorialità, erano conosciute le varietà campane e siciliane prima del 79 d.C. Crollato l’impero romano si perdono le tracce del limone fino all’arrivo degli Arabi.Ne avevano appreso dai persiani durante la loro espansione verso Oriente e lo trasferirono nelle terre che conquistavano tra le quali la Sicilia e l’Andalusia dove, grazie alla perizia di ingegneri dell’irrigazione, i giardini ne erano ricchi.

Nei frammenti dell’antico testo arabo di Ibn el- Wahshiyah, “Nabatean Agriculture”, nel 903 si descrive il limone chiamato “hasia” e il medico arabo Ibn Jamiya, nel Trattato sul limone di fine 1100, scrive della limonata e delle qualità medicamentose di essa.
Durante il Rinascimento il limone, apprezzato per le proprietà salutari, venne utilizzato per distillare essenze dalla scorza, dalle foglie e dai fiori. È in questo periodo che si sviluppa l’industria delle essenze e comincia a profilarsi la sua dimensione economica confermata nel 1646 anche dal gesuita Baptista Ferrarius, nella parte della sua opera dedicata al limone, alla coltura, alla lavorazione e all’esportazione (Hesperides, sive de malorum aureorum cultura et usu).
Qui le strade riconducono ancora una volta alla Sicilia e alla Campania e alla qualità dei limoni utilizzati per la produzione del limoncello. Ma non ci sono testimonianze se non che per qualcuno il limoncello era una bevanda consumata dai pescatori per ritemprarsi dalla brezza umida del mattino prima di andare a pesca e per qualcun altro sarebbero stati i monaci a prepararlo.
Ed invece sappiamo che la prima registrazione tecnica del marchio IGP del limoncello prodotto con le varietà campane si deve all’imprenditore Massimo Canale, a Capri nel 1988.
L’imprenditore aveva intuito la potenzialità della ricetta tramandata dalla nonna che agli inizi del 1900 lo preparava con il limone ovale del suo giardino per gli avventori del locale di ristorazione della sua famiglia. Ed era molto gradito e richiesto.
Intuizione confermata nel 2000 quando l’Istat inserisce il limoncello nel paniere usato per calcolare l’incremento mensile dell’inflazione. Ma altrettanto non vi è dubbio che il liquore nasce a casa, dalle preparazioni delle donne in cucina, forse anche degli uomini appassionati, e che la sua popolarità diventa potenzialità della produzione industriale che richiede le certificazioni di qualità.
Se in Campania il vero limoncello è fatto con il limone “sfusato amalfitano IGP”, proveniente esclusivamente dalla Penisola Sorrentina e da Amalfi, e con il “femminiello sorrentino”, altrimenti detto limone ovale di Sorrento IGP, anche in Sicilia, che produce circa il 90% dei limoni italiani e che vanta le tradizioni lasciate dagli arabi, è stato in uso il gustoso limoncello preparato dalle nonne con i limoni storici, di prima fioritura, coltivati nei giardini. In Sicilia le prime registrazioni IGP risalgono al 2002: il Femminello di Siracusa, il limone Interdonato di Messina, l’ Igp dell’Etna dove si vanta l’O.P Esperedio, fortemente connotato ai temi della sostenibilità ambientale.
Prof.ssa Mariolina Frisella, Dama del Priorato di Palermo

















Complimenti Prof.ssa Mariolina Frisella per questo testo che ci insegna tutta la historia del popolare limoncello.
Una bevanda meravigliosa della nostra carissima Sicilia
Grazie mille